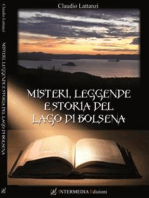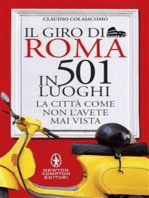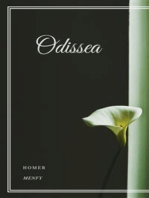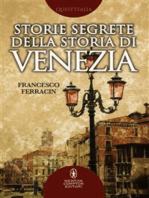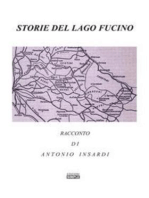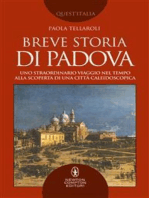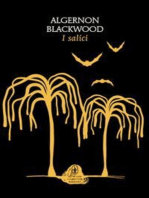Professional Documents
Culture Documents
Il Dio Volturno
Uploaded by
peppinoliber0 ratings0% found this document useful (0 votes)
525 views6 pagesCopyright
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
525 views6 pagesIl Dio Volturno
Uploaded by
peppinoliberCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 6
Il Dio Volturno
Come la maggioranza dei popoli antichi, anche i Romani,
mutuando dai Greci e questi ultimi verosimilmente dagli Egizi,
divinizzarono molto per tempo espressioni fisiche e naturalistiche
dell’ambiente di vita caratterizzandole col profilo di geni protettori
dei luoghi. Da qui il pullulare di ninfe e divinità minori specifiche
(Amadriadi, Oreadi, Naiadi, Meliadi, Nereidi, Oceanine, ecc.),
preposte a connotare i vari aspetti della vita e dell’ambiente in tutti
le sue manifestazioni. A queste entità erano riservati culti gioiosi e
semplici, espressioni di fede popolare e di dedizione spontanea.
Il dio Volturno, ancor prima che i Romani ne definissero la
connotazione mitica, godeva già presso le popolazioni locali di
una venerazione che era suscitata dall’impronta impressiva della
sua maestosità e dall’impeto delle sue acque ruggenti.
Verosimilmente però, anche nella Roma arcaica e monarchica,
questa divinità naturalistica godette di uno straordinario rispetto
ereditato dalla venerazione degli Etruschi per un altro nume
naturalistico, di carattere incerto, forse un perfido genio dalle
acque sinistre e costantemente ostili. Perché, al fine di scongiurare
la minaccia della natura violenta si finiva per venerare, sotto il
nome di un dio, un suo aspetto inquietante, una sua forza
selvaggia e irrompente, una espressione del paesaggio concepita
alla stregua forse di un enorme serpente dalle spire possenti che
scivola in mezzo a piane assolate per immergere l’ampia testa
dell’estuario nelle acque del mare. In fondo è così che nascono gli
dèi e quindi le religioni che ne organizzano le ritualità, le strutture
gerarchiche, la riflessione teologica, ecc.
Al dio Volturno dunque, venivano riservati onori e celebrazioni
importanti. Qualcuno ritenne addirittura che Volturnus fosse il
nome più antico dello stesso Tiber, il Tevere.
Georges Dumézil, che fu uno studioso di filologia comparata
della metà del secolo scorso, sulla scorta delle testimonianze più
remote, ritenne invece che con le Volturnalia, ovvero le
celebrazioni in onore di Volturnus, i Romani dell’epoca pre-
repubblicana non celebrassero affatto il dio turbolento delle acque
tortuose, ma quello di un vento caldo e frequente in questa
regione, lo scirocco.
Anche il nome Volturnus ha un’etimologia controversa. Lungi
dal soffermarmi sulle apparenze epidermiche del significato che
lascerebbero intendere un corso d’acqua dalle molte volute o giri,
come adombrerebbe l’ipotesi di Teodoro Mommsen, esso avrebbe
invece a che vedere con vultur, ovvero l’avvoltoio, l’uccello che
delle carogne trasportate dalle acque si cibava. L’etimo vultur,
avvoltoio, non genera sostantivi in italiano salvo che ad apparire
vagamente nella radice di Volturnus; vultur è presente invece in
molte lingue neolatine e non (avvoltoio si dice vulture - che è un
latinismo - in inglese; vautour in francese, ecc.).
Per altri studiosi il nome Volturnus avrebbe avuto origine dalla
denominazione di una città etrusca, Velthurna, che potrebbe essere
stata quella dell’antica Capua bagnata dal Fiume.
Ad ogni buon conto, i due profili: quello locale e quello romano
del Fiume finirono presto per confondersi e identificasi
nell’immagine antropomorfa del barbuto dio Volturno (Volturnus o
Vulturnus), “dai cerulei cigli” che richiama uno colore azzurro
delle sue acque, ormai smarrito.
Come alle divinità di importanza maggiore, anche a Volturnus
erano riservate festività solenni dette, come accennato,
Volturnalia, che avevano luogo nei mesi estivi. Le manifestazioni,
cui era preposto un Flàmine, ovvero un sacerdote così chiamato
perché preceduto da portatori di torce (anche se c’è chi ritiene
differente l’etimologia), si traducevano in offerta sacra alle acque
e in voti augurali affinché le inevitabili piene dei mesi invernali
non fossero portatrici di sventure e di carestie.
Con la Roma imperiale, ormai colta e lontana dalla schiettezza
delle tradizioni più antiche, smarrito pure il timore ancestrale che
la violenza irriducibile delle acque generava, la figura del dio
fluviale, forse quella zoomorfa del pitone, si modificò. Volturnus
assunse il profilo barbuto di un vecchio saggio e nerboruto, la
fronte coperta di arbusti palustri e delle celeberrime cannucce. Lo
si fece padre di Giuturna, una ninfa acquatica dalle chiome
lunghissime, protettrice delle fonti, che Virgilio indica come
sorella di Turno, il re dei Rutuli sconfitto da Enea che ne sposò la
promessa sposa, Lavinia.
Ad onore del vero non sono molte le testimonianze fisiche della
storia del Fiume nei corso dei secoli. Non restano che alcuni
elementi decorativi di un arco dell’anfiteatro romano dell’antica
Capua (oggi Santa Maria Capua Vetere) e la memoria nei versi
apologetici delle Silvae del poeta napoletano Papinio Stazio,
vissuto nel I sec. d.C. e dedicati all’imperatore Domiziano. Stazio,
nell’apologia che faceva di questo imperatore costruttore
dell’omonima strada, descriveva il ponte gagliardo che
attraversava il Fiume indifferente alla forza della sua corrente. Il
poeta interpretava lo spirito delle acque ribelli che erano costrette
ora a sostenere il peso onesto ma duro di quella straordinaria
costruzione. Si lamentava perciò, con gemiti inconsolabili
rimpiangendo il tempo in cui lo solcavano solo sandali dalla
chiglia piatta di pescatori di anguille.
Il Fiume ingabbiato non si sentiva adulato nemmeno
dall’immagine bugiarda della sua statua di travertino, sdraiata
come su un triclinio posta su un parapetto dal ponte, che lo
rappresentava con il volto barbuto e i capelli fluenti in un intreccio
turbinoso di erbe acquatiche e canne.
Di questo ponte antico restano ancora tracce nell’opus incertum
su cui sorge l’attuale Castello. E l’unica testimonianza storica
questa, legata alla vita del Fiume e alla storia della nostra città.
Una città abbandonata ormai e condannata a sparire dalle mappe
della storia con le vicende del Fiume che l’onora del nome, per
l’ignavia incolta di tanti condottieri eletti dalla cecità di gente
paziente quanto distratta. Il Fiume non è più dio ormai, non è più
storia sognante di quella bella età mitologica di cui siamo tutti
figli orfani.
Se volete che immagini il profilo del Volturno di oggi, ecco, io
non posso concepirlo più secondo i registri di lettura del passato
ormai onirico e lontano che esaltarono Stazio, Silio Italico e
Lucano. Questo povero Fiume non ha più cerulei cigli e non è
nemmeno biondo come il fratello Tiber e men che meno è più il
padre delle limpide acque della dolce Giuturna vergiliana. Non è
sicuramente più quel pitone immenso e contorto che tuffava il
largo capo nelle acque del Tirreno. Né riesco a immaginarlo con il
volto severo dalla barba fluente come le sue acque che fluenti non
son più da lustri. E nemmeno lo immagino col bel volto paffuto
della riproduzione ai piedi dello scalone del Comune, copia della
testa di un incerto imperatore, forse Tito, ma che di sicuro
iconograficamente non rappresenta il Volturno…
Rileggo nello scendere cupo delle acque, scorrenti quasi morte
fra cento città indifferenti, l’amore che il Fiume porta con sé per
una terra che bagna da almeno dieci millenni.
Scorre, ma chi può dire che questo scorrere, men che di
orgoglio è prova di un pianto silenzioso di abbandono. Gli dedico
un pensiero e vorrei fosse un canto, vorrei esaltarne il contorno
fiorendone le sponde, vorrei ravvivarne i colori per farlo degno del
vanto di specchiare il volto del cielo, come una volta…
Nessuna geografia credo fu più amata e funestata come quella
del Volturno, nel corso degli ultimi venticinque secoli, da quelli
che sulle sue sponde son nati e da chi qui venne a trovar rifugio.
Da chi soprattutto le sue acque macchiò del sangue di gente
sconosciuta che sulle sue ripe si confrontò per appagare smanie di
dominio, da Annibale nel corso del decennio più funesto della
seconda guerra Punica, ai Normanni sanguinari e affamati di terre,
dai Saraceni che qui fecero razzie di messi fiorenti e violenza a
donne imploranti, agli anglo-americani che vi trovarono la più
fiera resistenza nazista.
Tutto quello che ravviso, tutto ciò che resta del Volturno, sono
le cannucce sbiancate dal cloro e il brusio silenzioso del suo
scorrere nella sera, scuro come un lamento, senza più il coro
monocorde e interminato delle rane.
E resta pure il ricordo delle nostre infanzie sperdute, quando il
Fiume si faceva terrore delle nostre madri perché temuto,
mellifluo rapitore di bambini. Noi eravamo affascinati dalle sue
acque; era in fondo un compagno di giochi, un fratello più grande
al quale però ci avvicinavamo con circospezione, temendone la
furia e l’inganno sottile, l’inganno del fango scivoloso e dei gorghi
apparentemente innocenti. Ci adescava il Fiume, col suo brusio
sottile, con la dolcezza della sua onda lieve e bugiarda. E noi sulla
sua riva sinistra correvamo di soppiatto a giocare, proprio con quel
luzzo insidioso, il suo limo grigio, liscio e plastico che si piegava
sotto la forza delle nostre piccole dita scultrici. Correvamo quasi
attratti per magia; al Fiume ci legava infatti, perpetuamente, un
insondabile fato per aver bevuto l’acqua delle sue cannucce, come
l’elisir fatato di un mito o il filtro di un romanzo d’amore. Come
rintrona nella mente il ricordo di quelle urla materne a richiamare
figli, piezz e’ accise, che insofferenti di correzioni e incoscienti di
rischi, del Fiume vivevano affrontando l’esperienza del primo
nuoto, quasi un volo di giovani uccelli e primo battesimo del
coraggio!
Resta il ricordo di un tempo in cui esso non aveva bisogno di
essere identificato con un nome, perché nessuno di quelli che
abitano da millenni sulle sue rive l’ha mai chiamato Volturno. Non
ce n’è bisogno. Per essi il nome più dolce è o’ ciummo, il Fiume,
come il vezzeggiativo che si dà ad un bambino e l’accompagna
per tutta la vita smarrendo la sacralità del nome primo. O’
ciummo, le cui acque abbiamo bevute nel cavo della mano
lodando la sete, quelle acque che scorrendo fra le canne hanno da
atavico tempo l’omerico dono o la malasorte di provocare il
ritorno di chi le beve. Una volta era un privilegio, oggi è una
condanna.
Il Volturno per la sua gente è o’ ciumme, il Fiume per
eccellenza, non essendone concepiti altri e questo solo per
l’orgoglio di possederlo idealmente e idealmente appartenergli.
13.02.2008
Vittorio Russo
You might also like
- Quaderni Di Archeologia Nebroidea I - AbstractDocument31 pagesQuaderni Di Archeologia Nebroidea I - AbstractFrancesco ColluraNo ratings yet
- Gastronomia MolecolareDocument3 pagesGastronomia MolecolareGiorgio MattaNo ratings yet
- Giordana Niv 3Document12 pagesGiordana Niv 3PandexaNo ratings yet
- Culto Delle Acque in Magna Grecia PDFDocument28 pagesCulto Delle Acque in Magna Grecia PDFMaria Laura RomeroNo ratings yet
- Misteri, leggende e storia del lago di Bolsena: Affascinanti misteri e leggende nel lago di BolsenaFrom EverandMisteri, leggende e storia del lago di Bolsena: Affascinanti misteri e leggende nel lago di BolsenaNo ratings yet
- Le Origini Della Cultura Europea. Rivelazioni Della Linguistica Storica by Giovanni SemeranoDocument401 pagesLe Origini Della Cultura Europea. Rivelazioni Della Linguistica Storica by Giovanni SemeranoHúdson CanutoNo ratings yet
- Punta Campanella (Promontorio Ateneo)Document0 pagesPunta Campanella (Promontorio Ateneo)Vittorio FincatiNo ratings yet
- I Miti e Le Leggende Di SiciliaDocument13 pagesI Miti e Le Leggende Di SiciliaLietta DeganiNo ratings yet
- Il Mostro Apocalittico Di - Cristiano SpilaDocument10 pagesIl Mostro Apocalittico Di - Cristiano SpilaKyashan NahsaykNo ratings yet
- Il Canto di Imbra: Utopia di un viaggio nel MediterraneoFrom EverandIl Canto di Imbra: Utopia di un viaggio nel MediterraneoNo ratings yet
- Jack Williamson - L'Impero Dell'OscuroDocument146 pagesJack Williamson - L'Impero Dell'OscurotonicasNo ratings yet
- Flavio Frezza - "Trossolum", "Le Tròsciole" e "Le Tròsce de Le Vacche" Su Un'etimologia Fantasiosa Di Un Toponimo Locale - Loggetta Gennaio 2011 N 4Document3 pagesFlavio Frezza - "Trossolum", "Le Tròsciole" e "Le Tròsce de Le Vacche" Su Un'etimologia Fantasiosa Di Un Toponimo Locale - Loggetta Gennaio 2011 N 4Flavio FrezzaNo ratings yet
- La Leggenda Di ColapesceDocument42 pagesLa Leggenda Di ColapesceGabriele BradipoNo ratings yet
- 101 cose da fare a Roma almeno una volta nella vitaFrom Everand101 cose da fare a Roma almeno una volta nella vitaRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2)
- Il Nome Segreto Di RomaDocument3 pagesIl Nome Segreto Di Romaalessandro_sinibaldi6014100% (1)
- Manduria e PandosiaDocument29 pagesManduria e Pandosiaalessandrogiucastro2085No ratings yet
- All'origine del Mito - Storie e racconti e divinità del mondo classicoFrom EverandAll'origine del Mito - Storie e racconti e divinità del mondo classicoNo ratings yet
- Docsity Parafrasi Sonetti Romani BaldiDocument13 pagesDocsity Parafrasi Sonetti Romani Baldigiulia vighettiNo ratings yet
- Speciale Terremoto MessinaDocument26 pagesSpeciale Terremoto MessinaGiovanni LombardoNo ratings yet
- Le Monete Dei Possedimenti Veneziani Di Oltremare e Di Terraferma / Descr. Ed Illustrate Da Vincenzo LazariDocument213 pagesLe Monete Dei Possedimenti Veneziani Di Oltremare e Di Terraferma / Descr. Ed Illustrate Da Vincenzo LazariDigital Library Numis (DLN)100% (2)
- Il Firmamento Sensi Lettere e SegniDocument6 pagesIl Firmamento Sensi Lettere e SegnigurzibusNo ratings yet
- Rito WesakDocument3 pagesRito WesakIshtar AstarteNo ratings yet
- 2017 Mazda CX 3Document747 pages2017 Mazda CX 3Paolo StoppaNo ratings yet
- Il Tornado 542Document36 pagesIl Tornado 542liberfreeNo ratings yet
- Esercizi FisicaDocument52 pagesEsercizi FisicaEnrico ApollonioNo ratings yet
- Georges DumézilDocument4 pagesGeorges DumézilBlumenbachNo ratings yet
- 12 Marzo 1977. L'Ultima InsurrezioneDocument3 pages12 Marzo 1977. L'Ultima InsurrezioneAlessandro BaccarinNo ratings yet